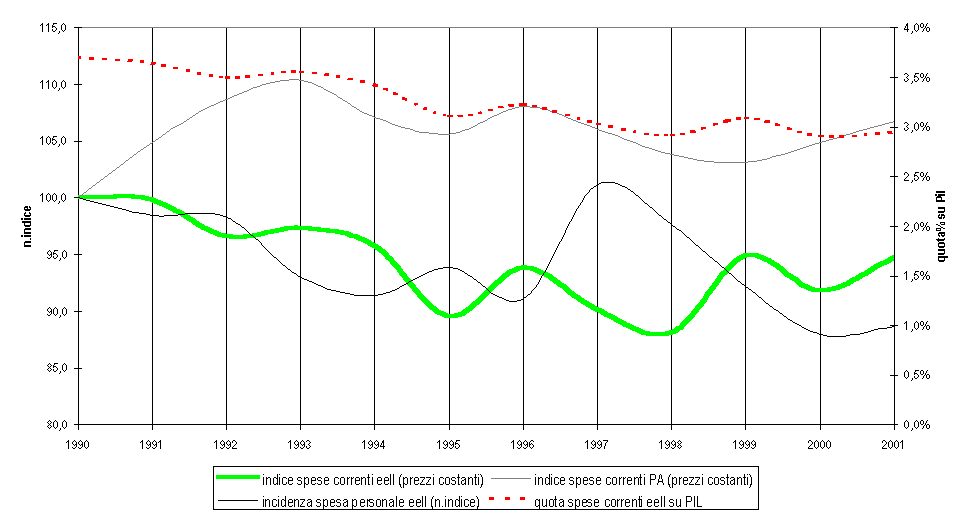IL FEDERALISMO TRADITO Tra centralismo e caos
L’atteggiamento della maggioranza di centrodestra verso la questione dei poteri e del federalismo appare, a dir poco, confuso e contraddittorio.
Né potrebbe essere altrimenti. La formazione gerarchico-aziendalistica di Forza Italia (che mal si concilia con l’articolazione e l’autonomia dei poteri), le note posizioni stataliste di Alleanza Nazionale e infine la concezione del ruolo dello Stato propria della cultura di tanti postdemocristiani, stridono con l’esigenza politico-elettorale dell’accordo con la Lega Nord, che ha legato la sua identità e la sua ragion d’essere alla realizzazione di un federalismo tanto proclamato quanto poco specificato nei contenuti concreti.
I contrasti sono stati accantonati ponendo il federalismo come uno dei cardini del Programma di governo della Casa della Libertà, che infatti recita: "Alle Regioni devono essere attribuite le responsabilità nel campo della politica scolastica, della politica sanitaria e la corresponsabilità della politica di difesa dei cittadini dalla criminalità urbana". Queste la parole. vediamo i fatti.
La devolution smentita
Proprio al suo esordio, nell’estate del 2001, il nuovo esecutivo ha ripristinato il Ministero della Sanità (che il centrosinistra con la sua riforma dei ministeri aveva soppresso, accorpando le competenze in un unico ministero del Welfare). Il risorto Ministero (ribattezzato "della Salute") non si vede cos’altro dovrebbe fare se non occuparsi di politica sanitaria, cosa che infatti sta puntualmente facendo.
Le iniziative del ministro dell’istruzione Moratti, al di là dei contenuti sbagliati (una valutazione di merito è contenuta nel capitolo "Scuola di serie A e di serie B"), si colloca nel solco che attribuisce allo Stato le politiche dell’istruzione. Anche in questo caso, la devolution non si vede.
Infine, c’è la cosiddetta "legge obiettivo" sulle infrastrutture, voluta dal ministro Lunardi, che toglie alle Regioni poteri ulteriori.
Mentre a livello ministeriale si compivano questi primi passi, l’intento meramente propagandistico della parola d’ordine della devolution emergeva chiaramente dalla povertà delle innovazioni introdotte dal Governo in materia di decentramento dei poteri (alle Regioni, in realtà, perché Comuni e Provincie non sono mai citati nei testi del centrodestra). In generale, si può dire che il centrodestra non ha compiuto alcun passo in avanti (ma ne ha fatti invece alcuni indietro) rispetto alla ben più significativa riforma federalista, quella approvata in chiusura di legislatura con i soli voti del centrosinistra, e successivamente confermata da un referendum popolare nell’ottobre 2001.
Il federalismo dell’Ulivo e quello del centrodestra
Infatti, la riforma del Titolo V della Costituzione ha già tracciato un nuovo quadro dei poteri normativi dello Stato e delle Regioni, assegnando allo Stato la competenza esclusiva sulle "norme generali sull’istruzione" e sulla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Tra queste ultime materie, viene comunemente fatta ricadere la sanità. Alle Regioni è invece stata attribuita la potestà normativa, entro la determinazione dei principi fondamentali fissati da norme statali (cosiddetta legislazione concorrente), nel campo dell’istruzione e della tutela della salute.
Dalla parte del Governo Berlusconi, dopo lungo dibattito che testimonia la divergenza di vedute tra le forze politiche della maggioranza su questo tema, all’inizio del 2002 è stata presentata una proposta che, lasciando inalterate le modifiche già apportate su iniziativa dell’Ulivo, si limita ad aggiungere un comma all’articolo 117 della Costituzione, con il quale verrebbero attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni le seguenti materie:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
Prospetto: le competenze sull’istruzione
- polizia locale.
allo Stato (legislazione esclusiva): norme generali sull’istruzione alle Regioni, entro i principi fondamentali fissati dallo Stato (legislazione concorrente): l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche alle Regioni (legislazione esclusiva)
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
Questa modifica costituzionale, se giungesse in porto, non aggiungerebbe molto alle competenze delle Regioni fissate dal nuovo Titolo V. Infatti, per la sanità le politiche generali resterebbero allo Stato, come pure la fissazione dei "livelli essenziali" delle prestazioni, mantenendo vincoli forti all’autonomia regionale (come del resto è ragionevole in una materia che concerne diritti di cittadinanza). Anche per l’istruzione, la devolution da un lato è assai poco innovativa, lasciando allo Stato le competenze generali; dall’altro introdurrebbe una preoccupante confusione nell’attribuzione dei poteri, con sovrapposizioni di competenze e responsabilità tra i diversi livelli di governo che sarebbe molto difficile interpretare e gestire.
Anche riguardo alla polizia locale, la devolution da un lato aggiungerebbe poco, dal momento che rimarrebbe comunque allo Stato la competenza esclusiva su "ordine pubblico e sicurezza". Dall’altro, introdurrebbe ulteriori elementi di confusione in una materia in cui, semmai, il problema concreto è quello di rafforzare l’efficienza e il coordinamento dei corpi di polizia esistenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), non certo di aggiungere ulteriori polizie locali.
La proposta di legge costituzionale sulla devolution, con la scarsa incisività e la molta confusione dei suoi contenuti, sembra assolvere principalmente il compito, soprattutto mediatico, di soddisfare l’elettorato leghista.
In assenza di alcun progresso nei lavori parlamentari sulla devolution, il pendolo delle tensioni all’interno dell’attuale maggioranza sembrava poter trovare il suo baricentro proprio nella riforma costituzionale varata dal centrosinistra.
Infatti, a giugno del 2002 il governo varava il disegno di legge La Loggia, che propone norme di attuazione del nuovo Titolo V, come varato dal centrosinistra: regola numerose questioni istituzionali concernenti i poteri e le competenze dello Stato e delle autonomie, comprese quelle in materia comunitaria e internazionale, il conferimento delle funzioni amministrative, la regolazione del contenzioso. Significativamente, però, non tratta in alcun modo la questione cruciale dell’autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione), rimandata a un "diverso e più complesso provvedimento", di cui ad oggi non vi è traccia. I ritardi nel presentare e nel far progredire questo provvedimento (tuttora lontano dall’approvazione) sono gravi anche per il forte contenzioso che nel frattempo si è aperto tra le autonomie e lo Stato. E’ infatti impressionante la quantità di ricorsi sollevati presso la Corte Costituzionale dalle autonomie contro lo Stato e da quest’ultimo contro le autonomie, per dirimere questioni di conflitto di competenze.
A settembre, con la presentazione della finanziaria per il 2003, il governo ha proposto nuovi pesanti interventi sull’autonomia finanziaria di regioni, comuni e province e forti tagli alla loro capacità di spesa. Contemporaneamente, su pressioni della Lega Nord, è iniziata la discussione parlamentare sulla devolution e sono ripresi i lavori sul disegno di legge La Loggia. Sembra quindi che, intorno al federalismo, ferva oggi un certo attivismo del centrodestra. In realtà, la maggioranza si muove in modo molto scoordinato, quasi schizofenico: da un lato segue la Lega Nord, proponendo ulteriori modifiche alla Costituzione vigente che, come abbiamo visto, nei contenuti sono poco incisive e piuttosto confuse; comunque, richiedono tempi molto lunghi per l’approvazione. Dall’altro lato, sembra voler dare attuazione al Titolo V, come innovato su iniziativa del centrosinistra, ma con evidenti timidezze e ritardi, e con la riprovevole esclusione della questione della autonomia finanziaria, rimandata a data da destinarsi, probabilmente a quando avrà concluso i lavori l’Alta Commissione di Studio per la definizione dei principi generali del federalismo fiscale, proposta con la finanziaria per il 2003. Intanto, nell’immediato la stessa finanziaria, mossa dall’esigenza di "fare cassa", interviene con inusitata pesantezza centralistica a tagliare i bilanci e a sopprimere l’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali. Dove approderà il centrodestra, a quale disegno di federalismo condurrà il Paese? Difficile dirlo, difficile fare previsioni, di fronte a disegni poco chiari e soprattutto poco coerenti tra loro.
Non può escludersi che alla fine possa prevalere l’orientamento di non dare attuazione alla modifica del Titolo V, di rimettere tutto in discussione, magari accusando l’attuale opposizione di aver introdotto una riforma inattuabile. A quel punto gli esiti politici potrebbero essere imprevedibili. Comunque, ne soffrirebbe, e molto, il Paese.
L’autonomia finanziaria negata
E’ facile affermare che si vuole più federalismo. Nei fatti il banco di prova essenziale sono l’effettivo potenziamento dell’autonomia finanziaria degli enti, cioè dello strumento concreto per attuarla. Su questo versante, l’avvento del Governo Berlusconi segna una pericolosa inversione di tendenza. E’ qui che avviene il tradimento del federalismo, nella negazione dell’autonomia finanziaria, della possibilità per regioni, province e comuni di gestire una autonoma e responsabile politica di bilancio.
E’ importante che le regioni e gli enti locali siano dotati di tributi propri di dimensioni consistenti, di cui possano manovrare le aliquote; che i trasferimenti dallo stato siano in larga misura non vincolati; e che il loro ammontare non sia deciso e contrattato di anno in anno, ma su un orizzonte più lungo, per poter dare la possibilità di una effettiva programmazione pluriennale.
E’ importante che i tributi locali siano distinti da quelli statali, chiaramente individuabili da parte del contribuente: dev’essere chiaro quale livello di governo aumenta o riduce le imposte, e perché. Una gestione del bilancio regionale (comunale o provinciale) responsabile ed effettivamente autonoma può e deve essere coerente con gli obiettivi complessivi del patto di stabilità, con un monitoraggio dei risultati dei saldi di bilancio, ma senza interferenze dello stato sulla gestione di singoli comparti di spesa o di entrata. Altrimenti si crea un finto federalismo. Si dà maggior potere a livello politico locale, ma senza l’autonomia e la responsabilità politica nei confronti del cittadino, al contempo fruitore di servizi, contribuente ed elettore.
Proprio questo, purtroppo, è quanto è accaduto in questo anno e mezzo, soprattutto con le due leggi finanziarie per il 2002 e per il 2003.
Interferenze nell’autonomia gestionale degli enti, irrigidimenti del patto di stabilità interno, forti tagli alle disponibilità finanziarie, interventi soppressivi o modificativi non concordati su tributi locali, blocco della facoltà di manovrare le aliquote dell’Irap e delle addizionali regionali e comunali all’Irpef, finte compartecipazioni all’Irpef, tutto all’insegna della peggiore tradizione centralistica dei decenni scorsi, tutto in netto contrasto con gli sbandierati intenti programmatici.
Soprattutto, in modo evidente e accentuato con la finanziaria per il 2003, si torna al vecchio metodo delle politiche di bilancio centralistiche, con le quali lo stato imponeva agli enti decentrati l’onere dell’aggiustamento dei conti. Incapace di affrontare il costo politico del taglio delle proprie spese, scaricava il compito su regioni, comuni e province. Prive di autonomia di bilancio, queste amministrazioni erano spinte a ricorrere all’indebitamento, spesso "sommerso" (cioè con fornitori e banche): non si risanava il disavanzo, si accentuava la deresponsabilizzazione degli amministratori locali. Rispetto a ieri, l’aggravante è data dal fatto che oggi lo stato non rinuncia a concedere sgravi fiscali (seppure limitati) sulle proprie imposte, per mantenere le promesse elettorali. Sempre a fini prevalentemente mediatici, si blocca la possibilità di manovrare le aliquote dei tributi locali, per evitare qualsiasi rischio di aumento. Ma si dimentica che l’unico metodo efficace per contenere i disavanzi è quello della responsabilità finanziaria, del vaglio del cittadino contemporaneamente elettore, contribuente e fruitori di servizi.
In definitiva, si sta tornando alle vecchie logiche degli anni Ottanta, quando non esisteva una vera autonomia finanziaria, i governi locali non rispondevano direttamente all’elettorato e non vi era ancora una radicata cultura della responsabilità e dell’autonomia degli enti.
E’ chiaro il tentativo di mettere a freno l’autonomismo locale, concedendo forse qualche maggiore spazio di potere normativo alle regioni, ma facendo perdere anche a esse, come vedremo in seguito, il fondamento necessario della propria autonomia che è rappresentato dalla disponibilità di margini effettivi e visibili di autonomia finanziaria, in particolare in materia tributaria. E tutto ciò non può essere certamente compensato dall’istituzione della "Alta commissione di studio" per la definizione dei principi generali del federalismo fiscale.
I provvedimenti in cui si articola il tema del federalismo tradito sono almeno quattro: le leggi finanziarie per il 2002 e quella proposta per il 2003; il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405); la delega fiscale, tuttora all’esame del Parlamento nei giorni in cui sono scritte queste note (inizio di novembre 2002).
A carico di Comuni e Province l’aggiustamento dei conti che non tornano
La finanziaria per il 2002 è stata orientata a un significativo contenimento delle risorse disponibili ed a una forte ingerenza dello Stato nell’autonomia finanziaria e gestionale degli enti locali. Questo quadro negativo è stato ulteriormente e pesantemente aggravato dalla proposta di legge finanziaria per il 2003.
Per aver chiaro lo scenario in cui si collocano questi provvedimenti, è importante sottolineare che, almeno nell’ultimo decennio, le spese degli enti locali non sono state affatto un fattore destabilizzante per la finanza pubblica. Nel grafico seguente sono elaborati alcuni dati ISTAT da cui si può facilmente verificare che:
- le spese correnti degli enti locali sono cresciute in misura di gran lunga inferiore a quello del complesso della pubblica amministrazione (PA);
- in termini reali, ovvero depurate della variazione dei prezzi misurata con il deflatore del Pil, le spese correnti sono diminuite dal 1990 al 2001 di oltre 5 punti percentuali, ad un tasso medio annuo dello 0,5%;
- la spesa per il personale degli enti locali è cresciuta in misura nettamente inferiore a quella del complesso della PA, riducendosi come quota sulle spese correnti dal 49% del 1990 al 44% del 2001;
- l’incidenza delle spese correnti degli enti locali sul PIL nominale si è ridotta dal 3,7% del 1990 al 2,9% del 2001.
I provvedimenti della Finanziaria per il 2002, in materia di regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali, erano stati gravi non tanto, o non solo, per la loro entità finanziaria, quanto per i vincoli gestionali imposti, sicuramente arcaici rispetto ai processi di autonomia e responsabilità seguiti con successo negli ultimi anni. Con la finanziaria per il 2003, oltre ai vincoli gestionali, è stato imposto agli enti locali un taglio di risorse di dimensioni spropositate. Infatti, dal Patto di stabilità interno sui comuni e sulle province proviene ben il 31% (circa 1.800 milioni di euro) dell’intera manovra di contenimento delle spese correnti delle pubbliche amministrazioni (pari a 5.805,4 milioni di euro; cfr. allegato 7 al disegno di legge per la finanziaria 2003).
Si tratta di un ammontare eccessivo, soprattutto rispetto alle tendenze della finanza locale osservate negli ultimi anni. E’ un modo, come abbiamo detto, di scaricare sulle istituzioni locali il costo della riduzione delle imposte statali, nonché del mancato contenimento delle altre spese della P.A. Il governo, cioè, scarica sui comuni e sulle province il "lavoro sporco" di scontentare i cittadini, attraverso tagli ai servizi erogati e rinvio del potenziamento dei servizi già erogati.
Ecco, in dettaglio, i principali interventi in materia di finanza locale approvati o in via di approvazione al momento in cui scriviamo.
Le regioni sotto attacco
- Interventi restrittivi dell’autonomia tributaria degli enti locali: è il caso della sospensione della facoltà di variare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF proposta con la finanziaria per il 2003 (su cui torneremo in seguito). Oppure dell’esenzione delle insegne dei locali commerciali dall’imposta di pubblicità, disposta dalla finanziaria per il 2002, con l’evidente intento di acquisire qualche credito presso i commercianti, categoria che il governo attuale ritiene far parte del suo blocco sociale di consenso. Questa modifica è intervenuta su un tributo tipicamente locale sul quale, in base al nuovo dettato costituzionale, lo Stato non ha competenza esclusiva.
- Alterazione, in chiave centralistica, della natura del Patto di stabilità interno, rafforzato da un non trascurabile taglio ai trasferimenti (per il triennio 2001, 2002, 2003 rispettivamente dell’1%, del 2% e del 3% per circa 111, 224 e 339 milioni di euro). Il Patto di stabilità interno è lo strumento, in vigore dal 1999, che definisce le regole per ripartire tra Stato ed Enti locali gli oneri derivanti dall’impegno assunto dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea. L’impegno, in sostanza, a diminuire anno dopo anno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. Finora il Patto vincolava a un obiettivo predeterminato il saldo tra alcune tipologie di spesa ed alcune tipologie di entrata (sono esclusi per esempio i trasferimenti), sicché i singoli enti potevano manovrare il bilancio, per conseguire l’obiettivo, sia mediante interventi sulle entrate che sulle spese. Con la finanziaria per il 2002 si è reintrodotto invece il controllo della spesa, mediante la fissazione di un tetto all’incremento sia degli impegni che dei pagamenti. In tal modo si è violata l’autonomia finanziaria nella gestione del bilancio, ritornando, di fatto, alle vecchie logiche del controllo centralistico sulle spese. Con la finanziaria del 2003, invece, si è adottata una tecnica dissimulatrice, nel senso che, da un lato, si ripristina formalmente il solo vincolo alla crescita del disavanzo (+3,6% rispetto a quello registrato nel 2001), dall’altro però si impone un limite alla spesa per l’acquisto di beni e servizi, il cui livello non deve eccedere quello del 2001. Sicché, a conti fatti, è imposto un blocco agli acquisti, tramutando così la crescita ammissibile del disavanzo in una riduzione, rispetto al 2001, di circa il 4,8%.
- Blocco alle assunzioni proposto in entrambe le finanziarie. Nella finanziaria per il 2002 la proposta iniziale del Governo fu mitigata dal Parlamento, che dispose il blocco solo per gli enti locali che avessero disatteso il patto di stabilità interno per l’anno 2001. Nel disegno di legge della finanziaria per il 2003, il Governo ha confermato quanto stabilito dal Parlamento l’anno precedente, ma ha esteso di nuovo il blocco alle assunzioni a tutti gli altri enti locali (quindi anche quelli rispettosi del Patto), almeno fino a che non intervenga un accordo tra Stato ed autonomie locali in merito al contenimento degli organici. Tale accordo, peraltro, risulta vincolato a due criteri: assunzioni nei limiti della metà dei cessati nel 2002 e nei limiti del 20% dei cessati (laddove il rapporto dipendenti–popolazione ecceda determinati livelli). Oltre ad essere incomprensibili, in quanto le assunzioni di personale non mostrano un andamento fuori controllo, questi interventi rappresentano una tipica interferenza centralistica.
- In entrambe le finanziarie il governo è poi intervenuto su una disposizione concernente la compartecipazione Irpef ai comuni, su cui vale la pena soffermarsi. Nella proposta di finanziaria per il 2002 il governo propose la riduzione della compartecipazione dal 4,5% all’1,5%. A fronte delle proteste si dichiarò pronto a reintrodurre l’aliquota del 4,5%, ma con il vincolo che l’entità delle risorse assegnabili come compartecipazione Irpef non superasse, per ciascun comune, i trasferimenti erariali dati. E così fu disposto. Grazie a tale vincolo, con la finanziaria per il 2003 il governo propone addirittura un aumento dal 4,5% al 6,5% della compartecipazione Irpef a favore dei comuni e ne introduce un’altra (nella misura dell’1%) a favore delle province. Probabilmente il prossimo anno si accorgerà che, se mantiene fermo il vincolo anzidetto, può proporre un’aliquota molto più alta, anche del 100%. Infatti, il risultato sarebbe, sempre, che ciascun ente locale percepirebbe le stesse identiche somme che avrebbe ricevuto dai trasferimenti erariali, cambiando solo il capitolo di spesa dl ministero dell’interno. Un’operazione tipicamente gattopardesca, una degenerazione della politica di bilancio, piegata a mero spot pubblicitario.
Le regioni sono coinvolte, al pari dei comuni e delle province, nelle modifiche che riguardano il Patto di stabilità interno (anche loro sono da ora vincolate non al controllo del disavanzo, ma a mantenere l’incremento della spesa corrente entro un tetto predeterminato, perdendo qualsiasi libertà di manovra tra entrate e uscite), nella sospensione della libertà di manovra dell’aliquota dell’addizionale Irpef e dell’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive) e nel blocco delle assunzioni.
Oltre a ciò le regioni vedono seriamente compromessa la propria autonomia finanziaria da un altro provvedimento: il progetto di delega fiscale presentato dal Ministro Tremonti, che prevede la graduale abolizione dell’Irap.
Un primo forte assaggio è contenuto nella finanziaria per il 2003, laddove da un lato (con un emendamento alla Camera) si blocca la possibilità di manovrare l’aliquota dell’Irap; dall’altro, si interviene sulla base imponibile dell’imposta. Il tutto a prescindere da qualsiasi accordo con le regioni. L’intervento sulla base imponibile comporta una riduzione del gettito pari a circa 521 milioni di euro, coperti nella manovra. Gran parte della perdita deriva dall’incremento (da 5.165 a 7.500 euro) della deduzione forfetaria dall’imponibile, già disposta dal centro-sinistra a favore dei soggetti con una base imponibile inferiore a 350 milioni di vecchie lire (circa 181 mila euro). Mentre la novità, più volte reclamizzata, di espungere il costo del lavoro dalla base imponibile dell’Irap, si è per ora tradotta nella misera proposta di una ulteriore deduzione pari a 2.000 euro per dipendente (per un massimo di cinque dipendenti), per i contribuenti "piccoli" con ricavi non superiori a 400 mila euro (800 milioni di vecchie lire). Questa ulteriore deduzione ha l’effetto di ridurre il gettito per 87 milioni di euro: complessivamente, il costo del lavoro per le imprese ammonta a oltre 400.000 milioni di euro. Risulta dunque una misura inefficace e puramente "ideologica", in quanto è formalmente rispettosa degli impegni politici assunti, ma non realizza percepibili effetti sull’obiettivo dichiarato di ridurre il costo del lavoro.
Se sparisse l’Irap: deve raddoppiare l’Irpeg?
Il punto più controverso, comunque, riguarda la prospettiva dell’abolizione dell’Irap. Innanzitutto, è dubbio che, alla luce della recente riforma costituzionale sul federalismo, lo Stato possa abolire un tributo regionale e intervenire, con sua legge, in materia di finanziamento delle regioni. In effetti la competenza esclusiva dello Stato si esplica sul "sistema tributario e contabile dello Stato", e del resto il titolo del disegno di legge presentato dal governo è: "Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale". Già il titolo dovrebbe far escludere qualsiasi intervento sul sistema fiscale regionale.
Nel proporre l’eliminazione dell’unico tributo che segna una presenza autonoma delle regioni nel rapporto col cittadino-contribuente-utente, la legge delega specifica che "restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell'Irap sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni". In altre parole, non sono i soldi in sé che vengono sottratti alle regioni, bensì la titolarità di questi enti a chiederli in prima persona ai contribuenti, e quindi a risponderne davanti a loro, nel bene e nel male.
Si dà il caso che il gettito dell’Irap nell’anno 2001 sia stato di circa 30 miliardi di euro (quasi 60 mila miliardi di lire), che coprono circa il 35% del totale delle uscite di parte corrente delle Regioni.
Il governo dice che queste risorse finanziarie non verranno a mancare, perché il tributo che viene eliminato sarà sostituito con una compartecipazione (agli introiti derivati da un’altra tassa statale) o con un trasferimento. Ma nel caso della compartecipazione, le Regioni non potrebbero disporre di alcuna potenziale manovra discrezionale sull’aumento delle entrate (perché la decisione sulla tassa statale rimane sempre comunque dello Stato). Va ricordato, a questo proposito, che il grado di manovrabilità dell’Irap, prima di essere soppresso dalla finanziaria per il 2003, poteva assicurare circa 5 miliardi di euro (10 mila miliardi di lire) alle regioni per sostenere le proprie decisioni di bilancio. Nel caso dei trasferimenti si avrebbe, in più, anche la dipendenza delle risorse regionali dalle decisioni annuali del bilancio statale. Come si diceva, lo Stato centrale si riprende tutte le sue prerogative e rigetta le Regioni in una posizione subalterna.
A proposito dell’ipotesi di far partecipare le regioni al gettito di una tassa statale, già nel Dpef presentato nell’estate 2001 Tremonti aveva annunciata l’abolizione dell’Irap, con assorbimento del gettito nell’Irpeg e compartecipazione al gettito di questa imposta.
Da un punto di vista finanziario (e anche politico), il governo ha sicuramente il diritto di chiamare le imprese a compensare con l’Irpeg l’abolizione dell’Irap. Ma è evidente che l’operazione non è gratis: trattandosi di due imposte di entità analoga (ciascuna sui 30 miliardi di euro) il "miracolo" potrebbe solo passare attraverso il raddoppio dell’Irpeg: più esattamente, della sua base imponibile, perché come più volte riaffermato l’aliquota dovrà calare al 33 per cento. Come la prenderebbero, le imprese, questa novità?
E’ abbastanza evidente che non se ne farà nulla, soprattutto alla luce delle attuali tendenze dei conti pubblici. Ma il governo resta comunque invischiato nelle sue promesse e nei suoi annunci di detassazione alle imprese, da un lato, e di mantenimento della risorse finanziarie delle regioni, dall’altro. Realisticamente, sarà costretto a disattendere entrambe. Per le imprese, abbiamo visto che il DL 209 di settembre 2002 ha aumentato le imposte. Per le regioni, tolta l’autonomia finanziaria sull’Irap, che tuttavia rimarrà in vita molto a lungo, si cercherà di "regionalizzare" il gettito dell’Irpeg.
Come però possa essere ripartito tra le regioni il gettito dell’Irpeg è problema tecnico non indifferente. Solo per fare un esempio: l’imposta versata dalle grandi imprese che operano a livello nazionale (banche, assicurazioni, trasporti, comunicazioni, elettricità, distribuzione, industria manifatturiera…) verrà attribuita alla regione in cui è localizzata la residenza legale, o verrà ripartita in base alla ripartizione territoriale dell’utile? La prima soluzione è chiaramente arbitraria e porta a risultati aberranti; la seconda comporta complessi sistemi di ripartizione territoriale, con notevoli complicazioni per i contribuenti interessati. L’emendamento Pagliarini alla finanziaria per il 2003, che affida alla "Alta commissione di studio" per l’attuazione del federalismo fiscale il compito di studiare possibili soluzioni, appare quanto mai opportuno, sul piano del metodo. Ma, nel merito, l’impresa cui è chiamata l’Alta Commissione appare davvero molto impegnativa. Per ora, l’emendamento Pagliarini ha subito suscitato vive e allarmate critiche da parte delle imprese, contrarie alla regionalizzazione dell’Irpeg e giustamente preoccupate dei connessi costi amministrativi.
Spariscono anche le addizionali ?
Un ulteriore attacco all’autonomia finanziaria delle regioni e dei comuni proviene, come si è visto, dalla sospensione della facoltà di variare le aliquote delle addizionali all’Irpef. E’ forse il preludio alla definitiva cancellazione di anche questa forma di autonomia tributaria?
Intanto, occorre rilevare che il modulo attuativo della riforma dell’Irpef, prevista dalla delega fiscale ed inserito nella proposta di finanziaria per il 2003, al fine di non ridurre il gettito delle addizionali esistenti per via della trasformazione di alcune detrazioni di imposta in deduzioni dall’imponibile, ha avuto un impatto negativo sul gettito delle addizionali. Infatti, aumenta il numero di contribuenti che non devono più l’Irpef erariale e quindi, in base alla norma che regola la materia, neanche l’addizionale. La perdita di gettito risulta quantificata e compensata per le regioni (circa 214 milioni di euro), ma non per i comuni, che quindi subiranno una ulteriore contrazione di risorse (stimabile in circa 40 milioni di euro).
Inoltre, una risposta sulle prospettive future è rintracciabile in alcune dichiarazioni rese dal vice ministro Baldassarri che, come riporta il Corriere della sera del 27 settembre, ha così dichiarato: la contropartita alla sospensione delle addizionali consiste nel "cominciare subito a ragionare di federalismo fiscale con l’obiettivo di passare dal criterio delle addizionali, che è un criterio poco federalista, al criterio della compartecipazione al gettito delle imposte.[…] Nei prossimi mesi e per la fine dell’anno sarà studiato tutto il progetto che segnerà il passaggio epocale verso le compartecipazioni".
Appare alquanto evidente la confusione che regna, laddove si ritiene che l’attribuzione di una specifica autonomia tributaria, consistente nella facoltà di variare le aliquote entro certi limiti, sia "poco federalista", rispetto alla assegnazione di una quota di tributi erariali sulla quale gli enti territoriali non esercitano alcun potere discrezionale. Una finanza locale basata esclusivamente sulle compartecipazioni si traduce in un "inganno" ai danni del contribuente, che non sa più distinguere a quale livello di governo paga cosa e perché, e nella deresponsabilizzazione degli amministratori locali. La loro "imprenditorialità" politica sarà tutta rivolta a ottenere maggiori quote di finanziamento dal centro, anziché ad amministrare bene e con efficienza il proprio bilancio, sottoponendo in modo trasparente le proprie scelte e responsabilità al vaglio dei cittadini, contemporaneamente elettori, contribuenti e fruitori di servizi.